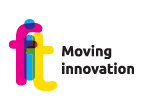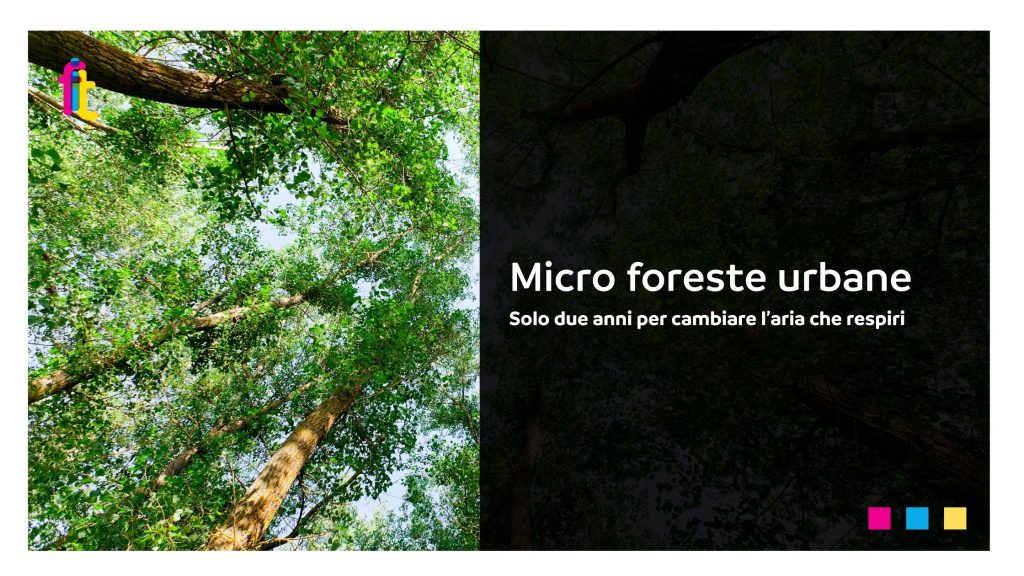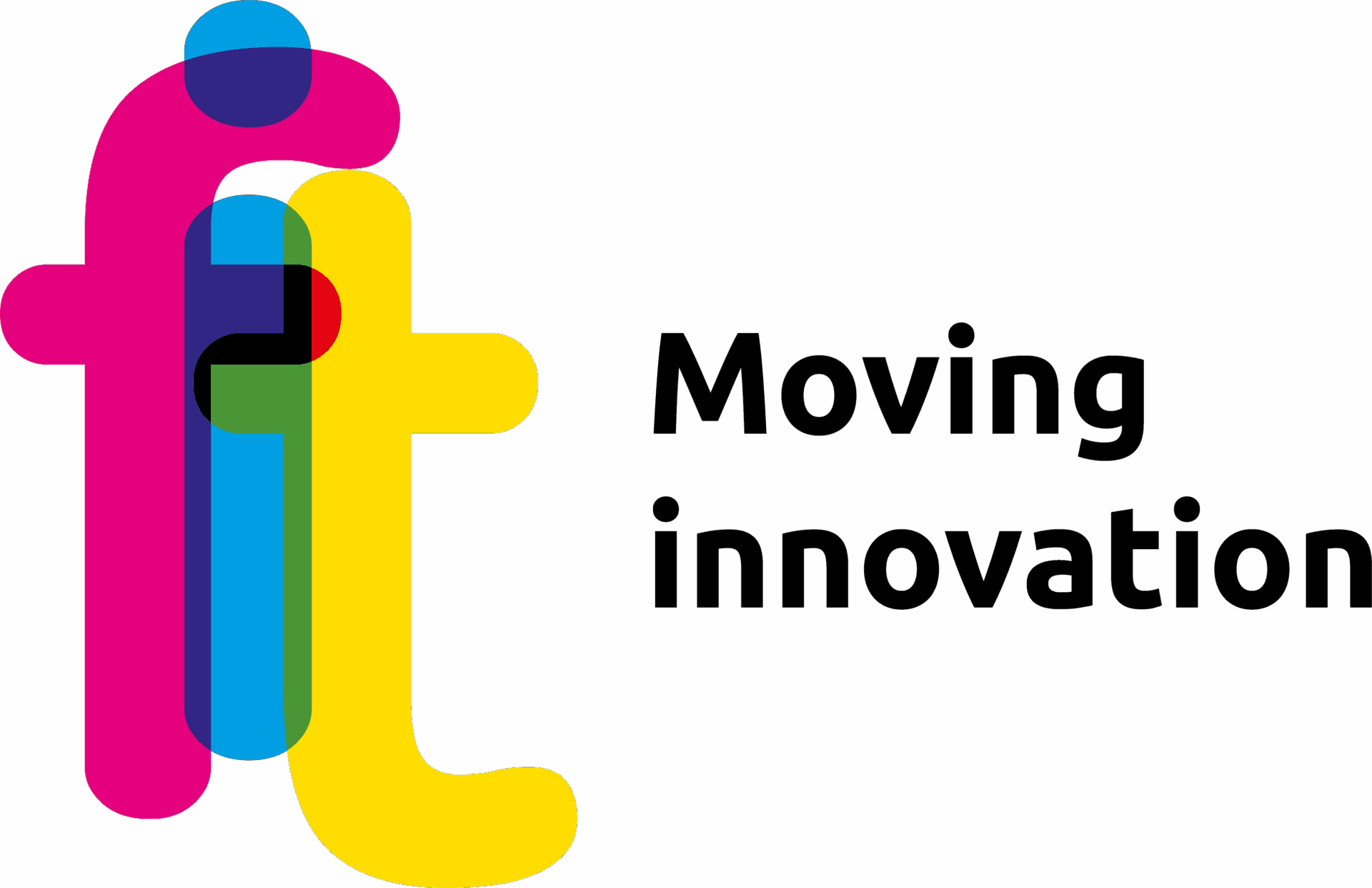Più accesso o più movimento? Ripensare la mobilità per città più eque
Per chi sono costruite le nostre città? Che impatto ha questo sulla vita di tutti i giorni?
La mobilità, ovvero la possibilità di muoversi liberamente all’interno della città, non dovrebbe essere intesa solo in termini di espansione delle infrastrutture, ma anche come la progettazione di sistemi che permettano a tutte le persone di raggiungere le proprie destinazioni in modo comodo, sicuro e accessibile, tenendo conto dei bisogni individuali e delle limitazioni personali.
Nel mondo, molte città si affrettano a espandere le proprie reti di trasporto, ma questo sforzo spesso trascura sfide più profonde e strutturali: segregazione economica, isolamento sociale e accesso diseguale ai servizi essenziali. Anche i sistemi di mobilità più avanzati possono fallire se sono pensati solo per spostare le persone più velocemente o più lontano. Alcune città stanno iniziando a ripensare il problema alla radice: la vera questione non è quanto ci si muove, ma quanto sia davvero possibile scegliere di non doversi muovere affatto.
Per chi si occupa di politiche urbane e mobilità, questo implica ripensare il concetto stesso di mobilità: non solo come movimento, ma come strumento di accesso e opportunità. La domanda cambia: non più “Come facciamo a spostare le persone più velocemente?”, ma “Come possiamo portare i servizi più vicino alle persone, affinché non debbano spostarsi?”
Questo nuovo approccio è in linea con le esigenze di coloro che hanno mobilità limitata o meno possibilità di spostarsi, con gli obiettivi di adattamento climatico e con la crescente richiesta di qualità della vita da parte dei cittadini.
Intervenire in questa direzione non richiede necessariamente investimenti proibitivi. Strategie come l’urbanismo tattico, i progetti pilota e l’uso di strumenti basati sui dati permettono di sperimentare soluzioni in modo agile, riducendo i rischi e facilitando l’adattamento e la scalabilità dei modelli più efficaci.
Parigi continua a investire nel modello della “città dei 15 minuti”, per garantire che i servizi essenziali, i luoghi di lavoro e gli spazi ricreativi siano facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta. L’obiettivo è ridurre i lunghi spostamenti e permettere ai cittadini di vivere in modo più locale e sostenibile.
Tuttavia, le infrastrutture fisiche da sole non bastano. Città come Helsinki e Stoccolma stanno dimostrando come la multimodalità digitale, ovvero la possibilità di accedere a servizi come sanità e istruzione da remoto, possa integrare l’infrastruttura fisica, soprattutto per ridurre gli spostamenti superflui delle persone con mobilità limitata. Non si tratta di sostituire il trasporto, ma di espandere le opzioni di accesso, in particolare nelle aree svantaggiate o periferiche. Naturalmente, ogni evoluzione digitale deve anche affrontare il divario tecnologico, per evitare di rafforzare le disuguaglianze già esistenti.
Anche l’Active Travel, ossia camminare e andare in bicicletta, gioca un ruolo importante nella costruzione di reti di trasporto urbano più eque, accessibili, economiche e sostenibili. Tuttavia, la pianificazione urbana ha storicamente privilegiato il traffico automobilistico, con conseguente sottovalutazione degli investimenti in infrastrutture per la mobilità attiva. Questo squilibrio ha impedito alle città di sviluppare sistemi davvero multimodali e inclusivi.
Tokyo, una delle città più funzionali al mondo, è anche tra le più pedonali—e non è un caso. L’uso dell’auto è regolato da politiche severe: per acquistare un veicolo, è obbligatorio dimostrare di disporre di un parcheggio privato entro 2 km dalla propria abitazione (il cosiddetto shako shomeisho). Il parcheggio notturno in strada è vietato e le tariffe sono tra le più alte al mondo, spesso superiori agli 8 euro l’ora. Queste misure scoraggiano efficacemente l’uso superfluo dell’auto privata e promuovono l’utilizzo del trasporto pubblico, tra i più avanzati al mondo.
Le strategie di moderazione del traffico giocano anch’esse un ruolo fondamentale nella costruzione di una mobilità più sicura e accessibile. La riduzione del limite di velocità da 50 km/h a 30 km/h incontra spesso resistenza, ma i dati raccontano un’altra realtà: la differenza nei tempi di percorrenza è generalmente inferiore a un minuto, mentre gli effetti sulla sicurezza e sulla vivibilità urbana sono notevoli.
A New York, l’introduzione del congestion pricing ha ridotto il traffico del 7,5%, equivalente a circa 43.000 veicoli in meno al giorno. In Italia, Bologna è diventata la prima grande città a implementare su larga scala il limite di velocità a 30 km/h. A un anno di distanza, i dati parlano chiaro: il traffico quotidiano è calato di oltre 11.000 veicoli, l’uso della bicicletta è aumentato del 10%, il bike sharing è cresciuto del 69%, il car sharing del 44% e il servizio ferroviario metropolitano (SFM) ha registrato un incremento del 31% nei passeggeri. Le emissioni di biossido di azoto, direttamente legate al traffico veicolare, sono diminuite del 29%, grazie anche a interventi infrastrutturali mirati come nuove piazze pedonali, piste ciclabili estese e attraversamenti più sicuri.
Dobbiamo quindi chiederci: chi sta escludendo oggi il nostro sistema di mobilità e perché? Ripensare la mobilità significa anche ridefinire i criteri di successo: non più la velocità o la quantità di traffico gestito, ma l’equità e l’accessibilità che un sistema è in grado di garantire.
A Edimburgo, la pianificazione urbana sta cambiando prospettiva, con alla base una riflessione più profonda su per chi sono davvero pensati gli spazi pubblici, con un’attenzione particolare al tema della sicurezza. Il trasporto, in questo contesto, gioca un ruolo cruciale: gli spostamenti notturni sono problematici, a causa della scarsa frequenza dei bus e dei costi elevati dei taxi. Per questo, la città vuole riprogettare marciapiedi, illuminazione, aree di sosta e accessibilità, con l’obiettivo di creare spazi più sicuri, vivibili e accessibili, in ogni momento della giornata.
Questi esempi ci invitano a riflettere e ricordano che non esiste una risposta unica, ma un insieme di strategie – infrastrutturali, digitali, normative e sociali – per trasformare e sostenere la mobilità in un motore di connessione, e non in un privilegio.